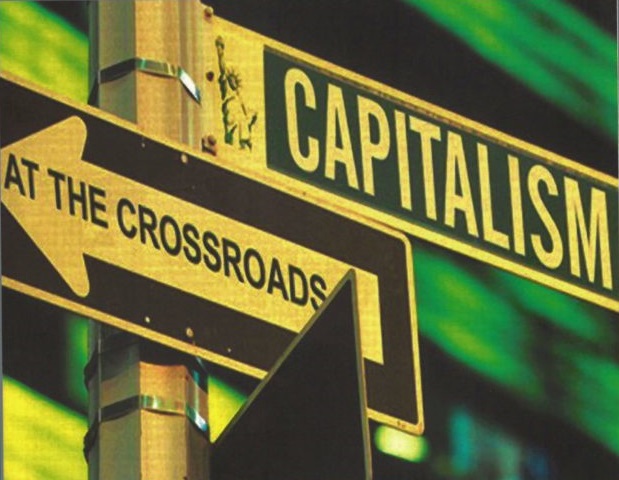Ho l’impressione che, a seguito della Corona-pandemia, l’ingigantimento dell’intervento degli Stati nella vita quotidiana dei cittadini/e e nelle economie nazionali – malgrado le gravissime responsabilità della grande maggioranza dei governi nella catastrofe epidemica mondiale (che ho trattato diffusamente nel mio scritto Evitiamoci invenzioni sul “capitalismo pandemico” del 12 aprile scorso, a cui rimando per una riflessione comune sul tema www.pierobernocchi.it) – lungi dal provocare forte opposizione e proteste, stia riportando a galla, almeno in Italia, un diffuso e persistente spirito novecentesco di statalismo, nostalgico qui da noi del “socialismo reale” o della statualità fascista o dell’epoca democristiana, a seconda degli orientamenti ideologici e politici. Storicamente, la convinzione della positività, di per sé, del dominio statale sull’economia e sulla produzione ha contagiato nel secolo scorso diverse generazioni e con una certa omogeneità, malgrado le gestioni di tale dominio siano state nella storia italica di ben variegato segno politico e culturale: così come forte è stata anche la confusione tra statale e pubblico, facendo molto spesso coincidere i due termini, come se il primo fosse garanzia di gestione egualitaria e democratica del bene comune, della produzione e dei suoi derivati.
Stante questa incombente confusione e in vista di un massiccio revival dell’intervento degli Stati nel controllo sociale e nella gestione produttiva ed economica, penso sia utile attualizzare la lettura di alcuni fondamentali nelle attuali forme del capitalismo, cioè concetti sovente mal interpretati e ancor più spesso equivocati, come ad esempio liberismo o globalizzazione, rivisitando nel contempo il ruolo degli Stati moderni e dei gestori di essi, ossia di quella vasta e assai potente classe da me definita borghesia di Stato, e considerata invece, secondo l’interpretazione sociologica più diffusa, semplice burocrazia. Alla radice di questo scritto c’è però anche un interrogativo profondo. E cioè: la crisi epocale, rappresentata dalle conseguenze economiche della pandemia, aprirà la strada ad un drastico ripensamento della visione del mondo in una parte considerevole dell’umanità e anche in settori significativi dei poteri costituiti, spingendoli a modificare almeno in parte modelli di sviluppo negativi; oppure tutto continuerà come prima, o addirittura con un’accelerazione della conflittualità e della divisione sociale, della brutalità dei rapporti economici, politici e produttivi? Non proverò a rispondere all’interrogativo, perché, pur se nell’esperienza ultra-secolare ad Ovest come a Est le fasi successive ai grandi traumi sociali, sanitari ed economici, non abbiano quasi mai visto emergere la parte “buona” dell’umanità ma casomai incattivirsi il “legno torto” di essa, è pur sempre bene mettere in conto la possibilità che situazioni inedite abbiano sviluppi altrettanto inediti, senza per questo fare professione di ottimismo obbligato.
Cercherò invece di delineare alcuni caratteri di una possibile società che non abbia più il suo principio-guida nella ricerca ossessiva e incontinente del profitto individuale e nella mercificazione onnivora dell’esistente. Non già perché veda una tale prospettiva a portata di mano, ma per offrire alcuni parametri di riferimento nei prevedibili conflitti che si apriranno un po’ ovunque nella fase post-pandemica e nel processo tortuoso della ricostruzione economica. Infine, questo scritto si propone anche di fare luce su alcune oscurità ed equivoci nella visione “di sinistra”, dell’iniziativa economica privata, troppo spesso infelicemente interpretata in blocco come espressione capitalistica tout court, malgrado essa sia nata con l’umanità e, a dispetto delle visioni assolutistiche del defunto “socialismo reale”, continuerà presumibilmente con essa a convivere anche nel secolo corrente.
Lo Stato come capitalista collettivo e l’utopia del liberismo
L’intera parabola storica delle società “socialiste” del Novecento dovrebbe aver dimostrato definitivamente come l’essenza della proprietà capitalistica sia qualcosa di più sostanziale rispetto alle pure forme giuridiche del possesso dei mezzi di produzione da parte di singoli o di gruppi di individui: cioè, il possesso dei principali mezzi di produzione non necessita obbligatoriamente della proprietà personale (di singoli o di famiglie) sancita per legge. Nella sostanza, si può avere proprietà da parte del capitale nazionale “pubblico”, gestito in forma dicapitalismo di Stato, come si può ben osservare oggi in Cina ancor più nettamente che nell’Est europeo novecentesco: e in tal senso, pur senza proprietà individuale, la possibilità per gruppi sociali, garantita dal monopolio del potere statuale, di usare i mezzi di produzione e la ricchezza generata a propria discrezione e secondo i propri interessi, non fa avanzare di un passo l’eguaglianza e la giustizia sociale. Pur con le dovute differenze da paese a paese, possiamo leggere la struttura economico-sociale dell’Urss dagli anni’20 all’89 e degli altri paesi dell’Est europeo come un capitalismo di Stato pianificato, una sorta di gigantesco trust nazionale, diretto e gestito assolutisticamente dal Partito unico, coesistente con forme assolutamente subordinate di proprietà cooperativo-collettivistica nelle campagne e marginalmente nelle città o – nel caso odierno della Cina, che ha portato all’apogeo e al massimo successo tale modello – con forme di proprietà privata da parte di gruppi multinazionali sotto il controllo politico del Partito-Stato. In tali paesi la statalizzazione dei mezzi di produzione e la scomparsa dei capitalisti individuali non hanno provocato la fine del processo di valorizzazione del capitale (ben modesto nell’Urss rispetto all’accelerazione imposta nella Cina attuale), né tantomeno la socializzazione – cioè l’uso sociale democraticamente organizzato, secondo criteri condivisi – dei mezzi produttivi e finanziari fondamentali e della distribuzione della ricchezza.
Il colossale abbaglio teorico e politico che ha portato a confondere l’eliminazione della proprietà privata individuale con la fine del processo di produzione capitalistica – e di conseguenza generando l’esaltazione del carattere progressista del monopolio statuale sui mezzi di produzione – ha avuto un rilevantissimo corrispettivo anche ad Ovest. La quasi totalità del pensiero marxista e delle organizzazioni politiche, sindacali e sociali richiamantisi al socialismo e al comunismo hanno pressoché sempre sottolineato acriticamente la positività della statalizzazione dei mezzi di produzione, confondendo proprietà statale e proprietà sociale. Nel cuore stesso della elaborazione teorica di Marx e Engels, ci fu una sorprendente sottovalutazione del ruolo degli Stati come capitalisti collettivi: tra le poche, seppur rilevanti, eccezioni quanto Engels scrisse nella ultima parte della sua vita nell’Anti-Duhring: “Se il modo di produzione capitalistico ha cominciato con il soppiantare gli operai, oggi esso soppianta i capitalisti e li relega tra la popolazione superflua…Ma né la trasformazione in società anonime, né in proprietà statale, sopprime il carattere di capitale delle forze produttive. Lo Stato moderno è una macchina essenzialmente capitalistica, il capitalista collettivo ideale. Quanto più si appropria le forze produttive, tanto più diventa un capitalista collettivo, tanto maggiore è il numero di cittadini che esso sfrutta. Il rapporto capitalistico non viene soppresso, viene invece spinto al suo apice”. E la Cina attuale rappresenta esattamente l’epifenomeno di questo processo di spinta verso l’apice capitalistico.
Anche nel pensiero marxista novecentesco in Italia, con poche eccezioni, il ruolo dello Stato, non come organo politico di controllo e repressione sbirresca al servizio dei padroni ma come vero e proprio capitalista collettivo,è stato grandemente sottovalutato, se non ignorato del tutto. In verità, fin dall’affermarsi dei primi Stati capitalisti (Inghilterra in primis), il nuovo sistema non è mai stato affare solo di singoli padroni privati in “libera” competizione per l’accaparramento dei mercati: il liberismo economico integrale, accompagnato dal non-interventismo in economia degli Stati e dalla piena e libera concorrenza pura, è sempre stato un’utopia del capitalismo, un sublime imbroglio teorico e politico per occultare l’unico vero liberismo, quello in materia di sregolato utilizzo della forza-lavoro indifesa. Se andiamo alla voce liberismo in un buon dizionario di Economia leggiamo che esso sarebbe un sistema “imperniato sulla libertà del mercato, in cui lo Stato si limita a garantire con norme giuridiche la piena libertà economica e a provvedere soltanto ai bisogni della collettività non soddisfacibili per iniziativa dei singoli, e nel quale c’è altrettanta piena libertà economica del commercio internazionale e si realizza un libero scambio, in contrapposizione al protezionismo economico e commerciale”. Ora, quale persona in buona fede potrebbe sostenere che l’attuale sistema economico mondiale sia strutturato sulla base di un libero scambioscevro da qualsiasi forma di protezionismi o presenze monopolistiche che falsifichino o annullino di fatto la “libertà del mercato”? Chi, non pagato per farlo, può negare che gli Stati più potenti agiscano in continuazione per violentare il fantasmatico libero mercato, tanto più dopo il ciclopico intervento – che ha movimentato cifre colossali e senza precedenti – dei principali Stati nazionali per tamponare la crisi esplosa nel 2008, processo che si accentuerà ulteriormente nei prossimi mesi per porre argine al tracollo economico post-pandemia ? Non è forse oggi più lontano che mai un mondo economico ove domanda e offerta si incontrerebberoliberamente in un mercato aperto e indenne da interventi politico-statuali?
Per la verità, il liberismo economico, come descritto dai cantori di Monsieur le Capital, non è mai esistito, fin dai primordi del capitalismo. Quest’ultimo non è mai stato, sua sponte, liberista. Lo ricordò qualche anno fa in maniera ironica il regista statunitense Michael Moore: “In realtà i capitalisti americani non credono al libero mercato e alla concorrenza. Sono tutti socialisti finché il governo si occupa di loro, impone alle amministrazioni locali di costruire qualsiasi cosa di cui abbiano bisogno, finché il governo diminuisce le loro tasse e aumenta quelle degli altri. In questo credono: ma non amano la concorrenza e preferiscono che qui le macchine giapponesi non vengano vendute. Poi si riempiono la bocca con l’impresa, il libero mercato e la competizione”.
L’unico liberismo vero che i singoli capitalisti hanno sempre desiderato è quello nel mercato del lavoro e neiservizi sociali. Solo in questi campi il padronato vorrebbe una concorrenza priva di regole – occupati contro disoccupati, stanziali contro migranti, giovani contro anziani, precari contro “stabili”, lavoro dipendente contro piccolo lavoro autonomo – che faccia abbassare il più possibile il costo del lavoro; e analoga concorrenza senza regole è auspicata nel campo dei servizi sociali e pubblici, quel territorio che i lavoratori/trici hanno conquistato in decenni di dure lotte, che si sono tradotte in istruzione, sanità e assistenza sociale più o meno gratuite, pensioni, e in Beni comuni non sottoposti alla legge del profitto. Solo in tal senso è corretto parlare di neoliberismo: mentre del tutto infondata – luogo comune assai diffuso negli anni passati anche all’interno del movimento altermondialista, indotto forse soprattutto dalla malcelata volontà di assolvere parecchi governi di “sinistra” per le loro malefatte – dovrebbe apparire oramai, soprattutto dopo i titanici interventi statuali anti-crisi del 2008 in poi, e quelli in preparazione per il post-pandemia, la tesi secondo la quale il neoliberismo avrebbe ridotto a simulacri gli Stati nazionali.
Alla base di questo eclatante errore teorico e politico c’è, come in gran parte della storia del pensiero “ di sinistra” del secolo scorso, una distorsione del vero ruolo degli Stati fin dal momento in cui il capitalismo divenne il sistema economico dominante in Occidente, delle loro funzioni da cervello capitalistico collettivo, in grado di limitare, controllare e incanalare in qualche modo l’”anarchismo” dei singoli capitalisti e le oscillazioni troppo violente dei cicli economici, di effettuare i grandi investimenti a lunga gittata nei settori di sviluppo (l’altro ieri nelle ferrovie e nell’elettrificazione, ieri nella chimica e nella meccanica, oggi nell’elettronica e nell’informatizzazione del mondo: insomma, dai treni per il Far West a Internet) ove i singoli capitali mai si impegnerebbero, nonché gli interventi riparatori dopo le crisi. Non è stata forse una lezione decisiva quella fornita dai principali Stati occidentali che nel 2008 hanno mobilitato somme colossali (migliaia di miliardi di dollari solo negli USA, che neanche una ventina delle principali multinazionali insieme avrebbero potuto mettere in campo), per tappare le mortali falle create da banche, conglomerati finanziari e assicurativi? In realtà, gli Stati (intendo quelli forti ed efficienti, non minati da corruzione, clientelismo e incompetenza, e dunque non certo quello italiano degli ultimi decenni) continuano ad adempiere – tanto più ora, di fronte alla crisi sanitaria ed economica indotta dal Corona-virus che minaccia di oscurare anche quella della Grande Depressione del 1929 – alle loro funzioni di capitalista collettivo e agli interventi di supporto, correzione, soccorso e stimolo dell’economia privata. E lo fa svolgendo, anche nelle fasi economiche “normali”, ruoli di sovvenzione (trasferisce ricchezza pubblica alle imprese private), di finanziatore (mette a disposizione altra ricchezza attraverso credito agevolato o, come nel caso di tanti interventi anti-crisi degli ultimi anni o in quelli avviati a pandemia in corso, di donazione gratuita), di committente (offre commesse e contratti), di imprenditore diretto (producendo in prima persona merci e servizi), di regolatore (difendendo il capitale nazionale dalla penetrazione dei concorrenti, o indirizzando certe funzioni produttive a vantaggio o a danno di questo o quel gruppo privato). E’ lo Stato a coprire le spalle a qualsiasi multinazionale, a fornirgli l’hardware, e cioè il sostegno politico, finanziario, tecnologico-scientifico e, quando occorre, militare. Non è vero che le multinazionali sono globalizzate al punto di essere disincarnate da un territorio, da una nazione, da uno Stato. Per quanto estese come presenza e operatività mondiale, esse hanno sempre bisogno di retrovie garantite a livello nazionale da una potente struttura statuale, politica, militare. Cosicché, il loro cuore, per quanto siano diffuse nel mondo le loro articolazioni periferiche, restanazionale, difeso da un intero apparato statale: e così il capitale di base, il grosso del gruppo dirigente, la sede del know how, i punti di forza scientifici, tecnici e politici. Che cosa sarebbe di Google o di Amazon, della Toyota, della Monsanto o della Sony se decidessero di abbandonare il potentissimo supporto/retroterra ad esse fornito dagli Usa o dal Giappone e si trasferissero – cuore, muscoli, cervello – ad esempio in Senegal o Bangla Desh?
La gestione da parte dei principali Stati della crisi mondiale esplosa nel 2008, e le loro forme, seppur conflittuali, di coordinamento di fronte all’emergenza, dovrebbero aver fatto piena luce rispetto a quella lettura sbagliata del sistema dominante che aveva avuto largo credito anche nel movimento altermondialista, da Seattle a Genova fino ai primi Forum Sociali mondiali di Porto Alegre: una interpretazione che vedeva il potere globale capitalistico incarnarsi in una specie di Coordinamento delle Multinazionali, una sorta di Spectre globalizzata ed extraistituzionale che, scavalcando ed ignorando anche gli Stati più potenti, avrebbe poi affidato ad organismi transnazionali ed extrastatuali come il Wto, il Fmi, il G8, la Banca Mondiale e la BCE per l’Europa, il ruolo di meri esecutori della sua volontà. Un errore peraltro aggravato dall’ineludibile constatazione che le strutture politico-economiche sovranazionali prima citate (Wto, Fmi, BM, BCE e G20 o G8), lungi dall’essere strutture autonome dai poteri statali, sono costituite, come ognuno può verificare, da funzionari pubblici degli Stati più potenti, nominati, stipendiati e revocati non certo dalle multinazionali ma dai governi dei paesi dominanti: insomma, un personale politico che attacca il carro dove vogliono gli Stati e i governi che in tal luogo lo hanno collocato. Di certo non è gente che può dettar legge ai paesi e agli Stati più forti e ai loro governi: piuttosto lo fa, ma a nome di tali Stati, nei confronti dei paesi più deboli e subordinati. In ogni caso tali strutture sovranazionali non sono le portabandiera del libero scambio e del libero mercato, una vera globalizzazione aperta dei mercati non è operante e le regole dei commerci sono contrattate politicamente tra le grandi potenze, in base ai rapporti di forza tra di esse: le quali poi cercano di imporre ai paesi più deboli la mutazione del “libero scambio” in scambio ineguale e coatto.
Le tesi sull’impotenza degli Stati nazionali, insomma, dovrebbero arrendersi alle confutazioni da parte della realtà, che pure in questi anni di crisi economica – e tanto più ora, nei prossimi mesi di catastrofe post-pandemica – ne ha dimostrato l’inconsistenza. Anche per la crisi in Europa, gli eventi di questi anni dovrebbero aver dimostrato come l’UE sia una struttura fragilissima al cui interno la Germania e i suoi satelliti cercano di imporre le proprie regole, conservando per sé una forte capacità di intervento e puntando a bloccare invece la possibilità di manovra degli Stati dell’area mediterranea mediante la camicia di forza dei vincoli di bilancio, del rapporto PIL-debito pubblico e del Fiscal Compact: tutte imposizioni che solo oggi, ad un passo dal baratro collettivo pandemico che inghiottirebbe anche la Germania e le arroganti economie del Nord Europa, sembrano venir meno. Mentre le burocrazie europee, malgrado i tentativi massicci di Draghi di ridurre l’austerity e l’egemonia tedesca, hanno confermato finora di non poter scavalcare i voleri degli Stati dominanti e di imporre una linea economica e politica davvero espansiva.
In verità, quella presunta separazione tra ruolo politico ed economico dello Stato, che avrebbe dovuto essere il segno forte della modernità, non è mai avvenuta sul serio e a fondo: e anzi, sia nel Novecento e tanto più in questo secolo, l’intreccio tra gestione politica ed economica è divenuto sempre più netto ed ha giocato, nella difesa e nello sviluppo del capitalismo, una funzione decisiva, senza la quale l’assenza di centralizzazione e direzione unificata del Sistema da parte dei capitali privati in lotta tra loro, incapaci di programmazione e di gestione unitaria sul piano globale, avrebbe probabilmente portato al tracollo l’intero sistema. Se il capitalismo ha potuto non solo sopravvivere ma riprendere slancio e forza dopo le due Guerre mondiali, se ha superato anche la Grande Depressione del ’29 e non è stato travolto neanche in questi dodici anni di crisi profonda e prolungata delle economie occidentali, e se riuscirà anche a non farsi abbattere dalla crisi sociale ed economica della pandemia, è e sarà grazie al massiccio intervento dei principali Stati, capitalisti collettivi in grado di intervenire con somme enormi in salvataggio dell’intero sistema. La fallimentare teoria della irrilevanza degli Stati a livello globale si è avvalsa anche di un’altrettanto fallace lettura della globalizzazione (che poi altro non é che l’interconnessione delle economie, degli scambi commerciali e finanziari, culturali, informativi e scientifici, in atto fin dall’Impero romano e che già Marx considerava, 170 anni fa, pienamente realizzata), mito ideologico ed efficace mascheratura delle responsabilità di Stati e governi nazionali, che ha fatto molte vittime, soprattutto a sinistra, negli ultimi anni. Secondo tale distorta lettura, la globalizzazione avrebbe provocato l’assoluto dominio dell’economia transnazionale sulla politica statuale. Ma anche questa è pura ideologia: il capitalismo non è davvero globalizzato, nel senso di pienamente integrato e svincolato dalle nazioni, più di quanto nel Novecento si sia mai realizzato il superimperialismo (concetto simile all’onirico Impero pacificato teorizzato da Hardt-Negri all’inizio di questo secolo) ipotizzato da Lenin: lo scontro tra i capitalismi è in atto più che mai, con il forte indebolimento dell’egemonia USA, la crescita vistosa della potenza cinese, il ritorno in campo della Russia, la crescita del ruolo dell’India. Altro che Impero pacificato: nell’ultimo ventennio abbiamo assistito ad uno squilibrio generale e ad un multilateralismo crescente che cancellano la tesi secondo la quale alcune strutture trans-nazionali avrebbero soppiantato il ruolo degli Stati e sottoposto ad un dominio omogeneo e centralizzato l’intero pianeta. Peraltro, è sorprendente, a proposito di tali istituzioni, che si dimentichi quanto esse siano nate tutte su iniziativa degli Stati più forti – Banche centrali, Banca dei Regolamenti Internazionali, aree monetarie come quella dell’euro con la BCE al centro, WTO, FMI e Banca mondiale. E tuttora tali istituzioni sono costituite da personale burocratico lì collocato dai governi degli Stati più forti, stipendiato lautamente mediante fondi statali, promosso o destituito a seconda della fedeltà agli interessi dei datori di lavoro.
Per giunta, è fallita la strategia statunitense dell’ultimo ventennio, quella della guerra permanente e globale per riconfermare un dominio storico e imporre agli Stati più deboli di spalancare le porte alla penetrazione economica e politica USA. Lungi dal dimostrare una egemonia incontrastata, un dominio imperiale senza ostacoli, come molti affermarono al momento dell’invasione dell’Afghanistan e dell’Iraq, il ricorso planetario all’arma bellica permanente ha messo in luce quanto tale potere sia vacillante sul piano prettamente economico, messo in discussione dagli Stati emergenti, che, di fronte alla crescente limitatezza delle risorse energetiche disponibili, sempre più ne rivendicano la riappropriazione dopo secoli di spoliazione, non facendosi più intimidire dalla macchina guerresca degli Stati Uniti. In realtà, l’enfasi sulle responsabilità della globalizzazione in un presunto ridimensionamento degli Stati (quelli forti, ovviamente) fa da corrispettivo all’utopia liberista di un mercato perfettamente concorrenziale, ove la statualità nazionale sarebbe assorbita nel mercato mondiale integrato, provocando l’inconsistenza delle politiche economiche e sociali nazionali: e a “sinistra” tale teoria è servita a giustificare il collaborazionismo a livello parlamentare e governativo.Senza dimenticare, infine, che laddove lo Stato è pressoché inesistente, non domina il “libero mercato” ma dittatorelli e mafie politiche ed economiche, che, liberi da regole e leggi, si spartiscono il bottino locale con le potenze esterne che ivi operano.
Un corrispettivo di questa lettura erronea del capitalismo moderno è stata ed è anche la teoria del governo unico delle banche, cioè del dominio mondiale delle banche e delle cordate finanziarie unite in una Santa Alleanza globale. Teoria fragilissima se solo si pensi che gli enormi interventi che hanno tenuto a galla il capitalismo europeo e statunitense – e che si spenderanno per farli sopravvivere anche alla crisi da corona-pandemia – non sono stati fatti da multinazionali finanziarie private ma dalle Banche centrali nazionali (Federal Reserve per gli USA e BCE per l’Europa). Ma, ragionando a più ampio respiro, va ricordato che l’ingigantimento della “bolla” finanziaria e il tentativo di uscire da una forte crisi di sovrapproduzione dilatando la produzione di denaro tramite denaro (per lo più fittizio) sono stati progettati e consentiti non da gruppi bancari o finanziari ma proprio dagli Stati principali. I governi degli Stati Uniti, in primo luogo, hanno deciso un’avventurosa, per il capitalismo globale, e distruttiva, per centinaia di milioni di persone nel mondo, deregulation finanziaria, nel tentativo di mantenere alti i livelli di consumo e di profitto. Così sintetizzerei cause e effetti del processo di accelerata finanziarizzazione globale, partendo dai tre fattori fondamentali che a mio giudizio lo hanno avviato.
1) La rivoluzione informatica ha provocato la più profonda trasformazione produttiva della storia, elevando enormemente la produttività: cosicché a parità di tempi di lavoro e personale impiegato, la produzione ha ingigantito la sua resa e cancellato migliaia di lavori e decine di milioni di occupati nel mondo, per cui all’aumento vistoso della produttività non è seguito un aumento del consumo, anzi si è determinata una diminuzione media di esso nell’Occidente sviluppato. 2) La propaganda di sistema sosteneva che il vero ostacolo all’estensione del benessere prodotto dal “libero mercato” era il blocco sovietico; ma il crollo di tale blocco non ha evitato che tuttora circa i due terzi degli abitanti della Terra siano fuori dal mercato capitalista che conta, mentre anche i mercati del Primo mondo sono intasati di merci, con i consumi mediamente ridotti a causa dell’impoverimento generalizzato dei salariati, dei pensionati e della middle class. Stante il grande incremento di produttività, la limitata estensione del mercato capitalista a livello mondiale e l’impoverimento di vasti strati sociali ad Occidente, il Sistema si è impantanato in una rilevante crisi da sovrapproduzione(o sottoconsumo). La produttività del lavoro é cresciuta più dei salari, aumentando lo scarto tra offerta e domanda e spingendo a cercare nuovi settori da mercificare nei servizi pubblici e nei Beni comuni, processo che però ha provocato un ulteriore taglio di salario (sociale) per vasti settori di popolazione, riducendo ulteriormente la richiesta di merci non primarie. 3) Ad aggravare ulteriormente gli effetti di questi due processi l’ultimo ventennio ha registrato una forte autonomizzazione, con recupero delle ricchezze e del capitale “pubblico” nazionale, da parte di parecchi paesi dell’ex-Terzo Mondo e la crescita poderosa di nuove economie che, oltre a produrre a buon mercato, hanno sfondato anche il muro della qualità nelle produzioni più innovative. Il tentativo degli Stati Uniti di fermare questo processo con la guerra globale è fallito miseramente.
Cosicché, al fine di evitare un’ulteriore riduzione dei consumi nonché la ri-partenza di lotte sociali intense, il capitalismo occidentale ha giocato una carta rischiosa, affidandosi ad una espansione del debito – soprattutto privato negli USA, pubblico in Europa – con la creazione di una gigantesca bolla cartacea che ha potenziato le lobbies della finanza e modificato gli obiettivi delle grandi imprese, che al profitto industriale hanno affiancato la massimizzazione del valore dei titoli, subordinando sovente la logica produttiva a quella della speculazione finanziaria. Però l’operazione poteva funzionare solo se l’economia occidentale fosse ripartita con forza e avesse ripreso l’egemonia mondiale e il pieno controllo delle risorse energetiche. Non essendo accaduto niente del genere, il rigonfiamento parossistico della bolla finanziaria non poteva durare oltre: e poiché alla ricchezza virtuale non ha corrisposto un aumento di quella reale, e dato che alla fin fine il capitalismo deve pur sempre affidarsi a beni reali, prodotti e consumati da persone del mondo reale, l’impalcatura di immondizia finanziaria è crollata nel 2008, dando l’avvio alla fase acuta della crisi. Insomma, non c’è stato un golpe del capitale finanziario; né la crisi che ha investito l’Occidente è stata solo o soprattutto finanziaria: la gigantesca bolla speculativa, più che la causa, ne è stata l’effetto, prodotto dal tentativo di risolvere una profonda crisi strutturale.
Peraltro, è pur vero che l’esistenza di una netta separazione tra capitale produttivo e finanziario – o addirittura di un conflitto sistemico tra i due – è un cavallo di battaglia da sempre dei riformatori del Capitale, quella vasta genìa di teorici, intellettuali e politici che vorrebbero rendere il capitalismo più accettabile, concentrandone la dannosità sul parassitismo del lato finanziario (con il corollario complottistico sull’azione sotterranea delle “lobbies pluto-giudaiche”) e la positività sul lato produttivo e industriale. Senonché, come anche lo svolgimento della crisi dell’ultimo decennio ha confermato, i due lati appartengono allo stesso corpo, alla stessa struttura, ove i capitali si intrecciano e finanza e produzione sono sovente nelle mani degli stessi soggetti: basterebbe solo studiare la trasformazione della più grande industria italiana del secolo scorso, la Fiat, nell’attuale realtà della FCA, per verificare lo stretto legame tra capitale finanziario e produttivo. Comunque, la via di fuga nelle superfetazioni finanziarie, nella spazzatura dei “derivati” e nelle bolle speculative estreme non ha funzionato: e anche se il potere delle organizzazioni finanziarie (pur sempre intrecciate a quelle produttive) è cresciuto nell’ultimo decennio, resta il fatto che alla fin fine il capitalismo deve pur sempre affidarsi a beni reali, prodotti e consumati da persone del mondo reale.
La burocrazia statale (o “borghesia di Stato”) ad Est e a Ovest
Analogamente alla sottovalutazione del ruolo dello Stato, il pensiero prevalente nella sinistra novecentesca anticapitalista ha pure minimizzato il vero ruolo del ceto/classe politica al potere sia ad Occidente sia nel “socialismo realizzato” dell’Est. Per quel che ha riguardato i paesi dell’Occidente, la lettura dominante, a sinistra, sul ruolo dei settori sociali che gestiscono gli Stati, le istituzioni e i governi è stata piuttosto monocorde, considerando tali settori una pura struttura di servizio per il padronato e per il grande capitale privato, una specie di funzionariato intercambiabile, servizievolmente prono nell’esecuzione dei comandi e delle direttive padronali. Oltre a cercare di dimostrare come tali settori sociali dominanti abbiano ruoli ben altrimenti importanti e decisivi negli Stati moderni, proverò anche a spiegare in maniera sintetica (per un approfondimento rimando ai miei Benicomunismo e Oltre il capitalismo) perché ritengo che al loro riguardo si possa usare il termine classe, piuttosto che quello di ceto burocratico. Userò come primo riferimento la definizione leniniana di “classe”: “Si chiamano classi quei grandi gruppi di persone che si distinguono tra loro per il posto che occupano in un sistema storicamente determinato di produzione sociale, per il loro rapporto, per lo più sanzionato e fissato da leggi, con i mezzi di produzione, per la loro funzione nell’organizzazione sociale del lavoro e, quindi, per il modo in cui ottengono e per la dimensione che ha quella parte di ricchezza sociale di cui dispongono. Le classi sono gruppi di persone, l’uno dei quali può appropriarsi il lavoro dell’altro grazie al differente posto che occupa in un determinato sistema di economia sociale”.
Tale definizione precisa correttamente che il rapporto di una classe con i mezzi di produzione è per lo più, ma non necessariamente, sanzionato da leggi, e in ogni caso non è da esse determinato in maniera decisiva: cioè, la formalizzazione giuridica del rapporto non è indispensabile perché una forma di possesso sostanziale esista di fatto. In secondo luogo, è il rapporto del gruppo con i mezzi di produzione, piuttosto che quello del singolo, che va preso in esame: cioè, la sostanza dei rapporti di possesso dei mezzi di produzione va ricercata nelle relazioni concrete, nelle funzioni materiali esercitate dal “gruppo di persone” nella struttura organizzata che decide sulla produzione e sulla distribuzione dei prodotti; e nelle rigide differenze tra i ruoli di tali gruppi derivate dalla divisione concreta del lavoro, che determinano poi anche le modalità e le dimensioni della loro appropriazione della ricchezza. Ora, se guardiamo ai concreti rapporti di produzione nei paesi “socialisti” del secolo scorso (o nei pochissimi che ancor oggi si definiscono tali), non è una forzatura definire classe quell’amplissimo gruppo sociale organizzato nel Partito-Stato, nel Sindacato unico e nella burocrazia statale che gestiva tutta la macchina produttiva e che di fatto era il possessore reale (nel senso di poter disporre a piacimento di essi) di tutti i principali mezzi di produzione e di distribuzione. Esso ne era proprietario collettivo in quanto, in assenza di pluralismo politico o di luoghi democratici di decisione pubblica sulla produzione e sulla distribuzione dei prodotti e della ricchezza all’interno della società, aveva illimitato potere decisionale sulle finalità, sulla organizzazione e modalità del processo produttivo e sulla distribuzione dei prodotti.
In parallelo, e tanto più nell’ultimo ventennio, anche nel capitalismo occidentale buona parte della proprietà è esercitata oramai in forma collettiva, come nelle società per azioni: la proprietà individuale anche ad Ovest è andata riducendosi e concentrandosi in gruppi di persone associate; e l’intreccio tra i detentori formali della proprietà (i capitalisti) e i gestori di questa proprietà (gli amministratori delegati, i CEO e affini) non è oramai meno inestricabile di quanto sia stato ad Est tra i membri di quella nomenclatura che definisco borghesia di Stato, ma che nel linguaggio “popolare” e nella pubblicistica politica corrente viene denominata burocrazia statale. Che comunque la definizione di classe non sia un errore sociologico o politico, dipende dal fatto che essa nel “socialismo reale” del XX secolo e negli ultimi epigoni sopravvissuti nel XXI (e anche riciclati con grande successo nel caso della Cina): a) possedeva di fatto i mezzi di produzione mediante la forma collettiva del Partito, la cui proprietà era anche sanzionata da leggi che, registrando la statalizzazione totale della produzione e della distribuzione, nonché il possesso del capitale nazionale da parte del Partito, dichiaravano per proprietà transitiva quest’ultimo vero proprietario dei mezzi di produzione principali; b) nell’organizzazione sociale del lavoro aveva una funzione insindacabile di direzione, decisione, controllo; e al contempo, nessun potere di accedere alle funzioni di gestione aveva la massa di salariati e settori popolari, privati di qualsiasi strumento democratico per rendere la proprietà statale effettiva proprietà comunitaria, sociale, davvero pubblica; c) grazie alla propria collocazione nei meccanismi produttivi, poteva appropriarsi indisturbata delle più cospicue quote del prodotto globale.
Soprattutto dopo la Rivoluzione russa, connotati non dissimili ha avuto ad Ovest, e in particolare nei paesi europei a partire dal ventennio di affermazione del nazi-fascismo, una classe “sorella” della borghesia di Stato dell’Est, in un quadro di estensione a dismisura delle funzioni dello Stato come gestore e garante del capitale nazionale, come imprenditore diretto, finanziatore, sperimentatore e investitore, appaltatore e compensatore (soprattutto nel caso di crisi) di capitale.
La concorrenza sociale, indotta dalla Rivoluzione russa, ha poi accelerato, in un Ovest incalzato dalle lotte popolari, la costruzione di un vasto Stato sociale, novità rilevantissima rispetto al capitalismo ottocentesco. Il timore di perdere il controllo dei salariati e dei settori popolari, sotto l’influsso delle attese suscitate dalla Rivoluzione d’Ottobre e con la spinta delle rivendicazioni dei lavoratori/trici in buona parte d’Europa e negli Stati Uniti, se da una parte produsse la reazione fascista e nazista, dall’altra ha portato, durante il Novecento, la quasi totalità degli Stati occidentali ad assumersi la gestione dell’istruzione di massa, dell’assistenza sanitaria universale e pressoché gratuita, delle pensioni di anzianità, vecchiaia, invalidità, di varie forme di reddito minimo garantito, dei sussidi di disoccupazione e delle altre forme di welfare. Insomma, si può dire che l’ingigantirsi ad Est del ruolo dello Stato e della borghesia di Stato (o burocrazia statale) ha provocato nel corso del secolo Ventesimo una catena di fenomeni emulativi ad Ovest e l’ingigantimento delle funzioni di un ceto/classe sociale sempre più esteso. In questo processo l’Italia è stata all’avanguardia. Il fascismo gettò le basi e realizzò negli anni Venti il più esteso capitalismo di Stato dell’Ovest europeo, a partire dall’avvio dell’IRI, che aveva il fine di eseguire la riorganizzazione tecnica, economica e finanziaria delle attività industriali del paese, di sviluppare l’industrializzazione in grande stile che i privati non potevano, non avendone i mezzi, accollarsi, in un momento di difficoltà finanziarie e industriali: e tale intervento determinò una svolta cruciale nel sistema, dimostrando la sua efficacia nelle fasi di crisi o di passaggio da un livello produttivo ad un altro. Efficacia confermata ai giorni nostri dalla vistosa crescita, nelle gerarchie economiche mondiali, di paesi come la Cina, l’India, e a livelli inferiori il Brasile nel decennio di gestione Lula, il Sud Africa, la Corea del Sud, Singapore, Taiwan, Indonesia e persino il Vietnam, paesi caratterizzati da un forte intervento e controllo dello Stato come gestore del capitale nazionale.
In Italia l’interconnessione tra capitalismo di Stato e privato non solo sopravvisse alle disgrazie belliche del fascismo, ma venne inserita nella Costituzione repubblicana (articoli 41 e seguenti, che sanzionarono la coesistenza di proprietà “pubblica” e privata) e rilanciato dalla DC, tramite strutture come le Partecipazioni statali, l’ENI, la Cassa del Mezzogiorno, la Gepi, e con il sostanziale consenso dei partiti della sinistra comunista e socialista, fino a fare dell’Italia il paese europeo con il più massiccio intervento statale nell’economia e l’edificazione di un sistema di capitalismo misto (intreccio tra capitalismo di Stato e privato) “più complesso – parole di Giuseppe Glisenti, storico manager dell’industria privata e di Stato dell’epoca – di tutto il mondo occidentale, a causa della molteplicità degli obiettivi assegnati all’intervento statale, che comprendono la ricostruzione e lo sviluppo dell’apparato industriale ma anche l’industrializzazione del Mezzogiorno, gli interventi anticongiunturali, l’acquisto di aziende private in via di chiusura, lo sviluppo di settori a tecnologia avanzata ed altri ancora”. Un capitalismo misto che, nella sua complessità, risultò superiore al capitalismo privato nella promozione dello sviluppo economico e industriale italiano, come orgogliosamente rivendicava ancora nella seconda metà degli anni Ottanta l’ex-ministro democristiano Cirino Pomicino:“Negli anni ’50 e ’60 c’è stata in Italia la grande invenzione delle Partecipazioni Statali, che hanno fatto investimenti in settori nei quali i privati non si sarebbero mai avventurati, facendo crescere il Paese; e oggi sono le uniche multinazionali che riequilibrano le distorsioni del capitalismo privato…Gli industriali sono arrivati sempre secondi dinanzi a tutte le novità del Paese”. E tale primazia si esercitò non solo battendo il capitale privato in quanto a capacità di investimenti, programmazione e previsioni a lungo termine, ma anche soccorrendolo a più riprese, come ricordava al capitalismo familiare italico “ingrato”, nel 1991, l’allora presidente dell’IRI Nobili: “L’intervento statale ha avuto un ruolo importante nello sviluppo del paese ed ha offerto un valido contraltare al settore privato, che al settore pubblico è ricorso ampiamente per scaricare aziende decotte, per ottenere un sistema infrastrutturale adeguato, per riprendersi aziende risanate….E’ stato decisivo il ruolo dell’IRI e delle Partecipazioni Statali nella ricostruzione del dopoguerra, nell’industrializzazione del Mezzogiorno, nel sostegno anticongiunturale e di salvataggio industriale, nella formazione del capitale di rischio, nella creazione delle grandi reti di servizio, nello sviluppo dei settori a tecnologia avanzata, nella formazione per la nuova imprenditoria”.
Dunque in Italia, ancor più che in altri paesi europei, quel funzionariato dotato di notevoli poteri che gestisce il capitale “pubblico” nazionale convive da tempo con il capitale privato, in forma sostanzialmente pacifica, visto che borghesia privata e di Stato hanno avuto ed hanno interessi non dissimili, per il legame con la crescita del capitale nazionale complessivo, con la penetrazione nel mercato mondiale e la protezione di quello nazionale dai concorrenti esteri, con l’abbassamento del costo del lavoro. Ma le centinaia di migliaia di politici, amministratori, gestori del capitale di Stato che occupano tutti i posti di comando ramificati ovunque nella società, non sono, come teorizza tanta vulgata “di sinistra”, semplici portaborse e cani da guardia del capitalismo privato. La borghesia di Stato – che dirige le istituzioni politiche, i governi e gli Stati, i partiti dominanti, la burocrazia finanziaria e industriale di Stato, le strutture amministrative, giudiziarie, poliziesche, militari, la quasi totalità dei mass-media mainstream e i sindacati di Stato – in quasi tutto l’Ovest non può essere considerata una acefala burocrazia suddita del capitale privato/individuale/familiare, quando è palese che muove masse di denaro e di conseguente potere decisamente superiori a quelle di quest’ultimo. Un solo esempio in tal senso, per stare al “qui ed ora” in Italia. Carlo Bonomi, il nuovo presidente della Confindustria, da molti/e considerata deus ex-machina che farebbe e disferebbe i governi, è assurto alla carica di presidente (dopo esserlo stato per l’Assolombarda) sulla base del suo ruolo di CEO della Synopo spa, una holding che distribuisce in Italia i prodotti della industria californiana Natus, apparecchiature e strutture tecniche per le cliniche di neurologia, neurochirurgia e riabilitazione sanitaria. Nel 2019 tale holding ha fatturato la risibile cifra di 17 milioni di euro, dando lavoro a circa 3600 persone, mentre Bonomi in tale società per azioni ha immesso la miserabile somma di 31 mila euro (!!), mentre gli utili sono stati di 250 mila euro. Ed ecco un illuminante raffronto con alcune strutture “pubbliche”: il Comune di Torino l’anno scorso ha “movimentato” nel bilancio annuale 1 miliardo e 230 milioni (circa 70 volte tanto la Synopo) con circa 10.500 dipendenti (quasi il triplo); il Comune di Bologna ha messo in campo un po’ più di un miliardo di euro (circa 60 volte tanto) con 4300 dipendenti; senza poi parlare di Milano con i suoi 3 miliardi di bilancio con 16 mila dipendenti e la città-record in materia, Roma, con bilancio di 4 miliardi e 600 milioni di euro e 48 mila dipendenti (per la verità, ad oscurare la holding di Bonomi basterebbe anche il comune di Perugia con il suo “fatturato” annuo di 500 milioni di euro). E a parte Bonomi e la Synopo, è tutta la struttura industriale italiana ad essere poca cosa come fatturato e come occupazione rispetto alle principali strutture statali, regionali e comunali che movimentano cifre assolutamente superiori e danno lavoro a molta più gente: e se questi raffronti non bastassero, ricordo infine che la FCA, la Fiat-Chrisler – che resta sempre la struttura industriale numero uno tra quelle con capitali in gran parte italiani – nel 2018 occupava circa 57 mila persone in Italia, cioé meno dei lavoratori/trici impiegati/e nei due comuni di Roma e Milano.
Tornando alle questioni generali sul tema, la sostituzione del funzionario al padrone individuale nella gestione di tanta parte del capitale e la non-indispensabilità della presenza del proprietario privato per il funzionamento dell’impresa furono per la verità già previste, ma quasi di sfuggita, pure da Marx e ancor più da Engels (come citato in precedenza), anche se poi a tali previsioni non conseguirono elaborazioni articolate sulle funzioni dello Stato come capitalista collettivo e dei suoi funzionari come gestori di quest’ultimo, né mutamenti nell’impostazione politica contenuta nel Manifesto del partito comunista, che di fatto costituì la Bibbia dell’orientamento politico dei comunisti marxiani per un buon secolo. Nel terzo libro del Capitale Marx scrisse ad esempio: “In seguito alla concentrazione dei mezzi di produzione e alla organizzazione sociale del lavoro, il modo capitalistico di produzione sopprime, sia pure in forme contrastanti, la proprietà individuale e il lavoro privato… Con lo sviluppo del credito lo stesso capitale monetario assume un carattere sociale, si concentra nelle banche e da queste, e non più dai suoi proprietari immediati, viene dato a prestito…e poiché d’altro lato il semplice dirigente, che non possiede il capitale, esercita tutte le funzioni effettive che spettano al capitalista operante, rimane unicamente il funzionario e il capitalista scompare dal processo di produzione come personaggio superfluo”.
Anche ad Ovest i funzionari del capitale di Stato hanno accresciuto la loro influenza e il loro potere negli ultimi decenni e ancor più da quando la crisi finanziaria ed economica del 2008 – e tanto più questo avverrà nei prossimi tempi di gestione statalista nazionale e planetaria della catastrofe pandemica – ha messo a nudo le debolezze della gran parte del capitalismo privato e familiare di fronte alle crisi. Insomma, non stiamo parlando di servi dei padroni ma di un vastissimo personale politico ed economico, dilagante nelle industrie e strutture economiche statalizzate o a capitale misto. Le crescenti funzioni di gestione del capitale e della ricchezza nazionale, nonché di controllo economico, sociale, politico – che nell’Ottocento e in una parte del Novecento erano riservate ad élites ristrette – coinvolgono ora fasce sempre più consistenti di persone. Per quel che riguarda l’Italia, dopo il decennio “rosso” 1968-77, vasti strati sociali sono stati promossi ai poteri e ai privilegi dell’ampia borghesia di Stato che è andata ad occupare, con centinaia di migliaia di individui, ogni luogo di gestione del capitale nazionale e della ricchezza “pubblica”. E ancora oggi, pure se vari settori sono stati privatizzati, quello che Prodi definì il capitalismo senza padroni, di marca statale, possiede ancora buona parte dell’apparato produttivo che conta, una enorme quota del capitale finanziario, oltre la metà dei mezzi di informazione, la quasi totalità dei servizi pubblici e della gestione dei Beni comuni e controlla i meccanismi-base del credito. E analoga risulta la situazione se guardiamo al personale della nomenclatura di Stato, insediato nei ministeri, nelle direzioni delle aziende, banche, amministrazioni varie, nazionali e locali, che è il tessuto gestionale di gran parte della ricchezza nazionale “pubblica”. La maggioranza di tale personale è intercambiabile, non è influenzato più di tanto dai cambi di governo: a garantire la continuità delle strutture restano in buona parte gli stessi, con poche aggiunte o sottrazioni a seconda dei risultati elettorali; e alla fin fine la stabilità di questo personale è persino maggiore di quella che si può vedere nei Consigli di amministrazione delle aziende a capitale privato.
Per la socializzazione dei Beni comuni
Come ho accennato all’inizio di questo scritto, immagino che centinaia di milioni di persone nel mondo si stiano domandando se la crisi epocale, provocata dalle conseguenze economiche del “confinamento” pandemico, aprirà la strada ad un drastico ripensamento della visione dell’organizzazione economica e sociale in una parte considerevole dell’umanità e anche in settori significativi dei poteri costituiti, spingendo a modificare almeno in parte modelli di sviluppo deleteri; oppure se tutto continuerà come prima, o addirittura con un’accelerazione della conflittualità e della divisione sociale. Non proverò a rispondere all’interrogativo, perché da situazioni così drammaticamente originali potrebbero derivare sviluppi altrettanto originali, senza per questo fare professioni inutili di fede. Ma credo possa essere di una qualche utilità tratteggiare (seppur molto sinteticamente rispetto a quanto ho fatto – in maniera giudicata molto ampia e approfondita – nei miei due ultimi volumi Benicomunismo, del 2012, e Oltre il capitalismo, del 2015) alcuni caratteri di una possibile società – che in tali scritti ho definito benicomunista, ma il termine non è essenziale – che non abbia più il suo principio-guida nella ricerca incontinente del profitto individuale e nella mercificazione onnivora dell’esistente. Indipendentemente dal fatto che si veda o meno all’orizzonte la possibilità di una tale prospettiva, ritengo infatti utile offrire alcuni parametri di riferimento, di comportamento e di direzione da seguire nei prevedibili conflitti che si apriranno un po’ ovunque nella fase post-pandemica e nel processo tortuoso della ripartenza economica, ponendo al centro di essi il tema cruciale dei Beni comuni, che fanno parte di una realtà variegata e mutevole, non definibile in maniera metastorica e a-temporale. In Italia, in epoca recente il termine Bene comune è stato usato dai COBAS nei primi anni di questo secolo per indicare come la scuola pubblica e l’istruzione fossero un bene generale e collettivo, la cui difesa e miglioramento non dovevano essere compito esclusivo dei lavoratori/trici del settore ma impegno globale di studenti, genitori e cittadini ostili ai processi di privatizzazione e mercificazione dell’educazione pubblica. Ma il termine, utilizzato successivamente in particolare dai movimenti in difesa dell’acqua pubblica, è arrivato ai più ampi settori della popolazione italiana attraverso la vittoria nei referendumsulla ri-pubblicizzazione dell’acqua e dei servizi locali (e contro il ripristino del nucleare) del giugno 2011, e si è poi diffuso in tutti i settori dei beni collettivi.
1) A mio parere va considerato Bene comune tutto ciò che la larga maggioranza della popolazione ritenga una ricchezza collettiva che esiga un controllo e una gestione pubblica e socializzata, in forme democratiche da stabilire ma di certo sottratta dalle mani sia del capitale privato sia della nomenclatura di Stato, dei politici professionisti e dei funzionari che gestiscono il capitale “pubblico”. Il che dovrebbe valere attualmente per la socializzazione di acqua, scuola e istruzione, sanità e salute, terra e sue produzioni basilari e regole dell’uso pubblico di essa e dell’ambiente, trasporti e energia, nonché per una parte significativa dei mezzi di informazione, comunicazione e conoscenza; ma anche per le principali produzioni industriali, strategiche ed essenziali, per il capitale “pubblico” e collettivo – quello che oggi è nelle mani dello Stato tramite la tassazione dei cittadini/e e le rendite e i profitti della produzione statale e del patrimonio mobiliare e immobiliare “pubblico”- e dunque anche per le principali strutture bancarie e finanziarie.
2) Se interpretiamo così la categoria dei Beni comuni, essa diviene ben più vasta, profonda e radicale che nella pubblicistica corrente. Affidare o restituire alla socializzazione democratica non solo istruzione e salute, acqua e ambiente, ma anche i principali beni industriali e finanziari di un paese, non può avvenire con il consenso dei potentati del profitto privato e della mercificazione globale. L’affermazione di un sistema del genere non si può dare come naturale evoluzione della società attuale, e deve mettere in conto un lacerante conflitto, le cui caratteristiche sono al momento imprevedibili ma con la possibilità di fortissime contrapposizione sociali e politiche, implicando una rottura con il sistema dominante o una sua drastica modifica che, almeno in teoria, non si può escludere che vengano favorite dalla tremenda congiuntura che seguirà alla pandemia.
3) Comunque, vanno sottolineati i caratteri di categoria mobile e mutevole: ciò che ieri poteva essere considerato uno dei Beni comuni essenziali, oggi potrebbe non necessitare più di una gestione collettiva, e viceversa. Negli anni ’60 e ‘70 del secolo scorso, in Occidente, il problema di evitare la mercificazione della istruzione e della sanità, dell’acqua o dello smaltimento dei rifiuti poteva sembrare pura esercitazione teorica: oggi è oggetto di una battaglia campale tra chi ne vuole fare i business del XXI secolo e i difensori degli interessi collettivi. In questi anni il controllo dell’energia è stata cruciale questione pubblica: ma se ieri il petrolio era il fulcro intorno a cui ruotava ogni questione energetica, oggi le forme alternative non inquinanti e rinnovabili sono considerate i veri Beni comuni, con la speranza che a breve il petrolio rientri tra le materie di scarso o nullo interesse pubblico. Nel dopoguerra, forse il passaggio di un ipotetico treno ad Alta velocità nella Val di Susa avrebbe potuto essere visto come fattore di progresso; oggi appare una iattura e il vero Bene comune è la conservazione dell’habitat naturale; e mezzo secolo chi considerava la stabilità del clima un Bene comune primario? Insomma, va messa in conto l’evoluzione storica del concetto, escludendone la sussunzione in un astratto ed eternizzato Bene Comune Universale.
4) Oltre ad essere cangianti nel tempo, i Beni comuni non sono affatto realtà a-conflittuali, e la loro differente valutazione a livello di massa può essere anche oggetto di aspri conflitti e divergenze, pure in una società post-capitalistica. Chi ha seguito in questi anni le problematiche sociali di alcuni paesi latinoamericani – fin quando sono stati guidati da governi progressisti, almeno sulla carta paladini dei Beni comuni – ha potuto osservare una vasta gamma di conflitti in seno al popolo proprio in merito a quali beni dovessero essere considerati comuni, e dunque salvaguardati. Ad esempio, i difensori dei diritti inalienabili della Pacha Mama (la Madre Terra di varie popolazioni indigene, cioè ogni porzione dell’ambiente naturale così come si è loro presentato storicamente) hanno ripetutamente considerato un oltraggio la deforestazione di intere aree o la deviazione del corso di fiumi per la costruzione di dighe e centrali idroelettriche. Di converso, però, altre popolazioni hanno valutato come Bene comune l’usufrutto di zone disboscate ove impiantare colture agricole e allevamenti; oppure, l’uso di energia elettrica grazie a nuove dighe in aree altrimenti carenti. Perciò, la definizione di cosa, in uno specifico periodo storico o paese, vada considerato Bene comune – e dunque socializzato e gestito collettivamente – deve avvenire mediante un processo di ampia partecipazione democratica, che metta in conto anche contrasti o conflitti e la necessità di mediazioni che raccolgano il massimo del consenso.
5) Quindi, nel quadro di una visione generale dei Beni comuni e della transizione verso una società che superi la centralità del profitto privato e della mercificazione generalizzata, ritengo assai negativa ogni riproposizione di miti ideologici come il Proletariato Unico del comunismo marxiano o di analoghi, astratti enti, classi, ceti, settori sociali considerati come omogenei, senza conflitti all’interno e per giunta in grado di rappresentare gli interessi generali. A mio giudizio, tali interessi unitari e globali possono esistere, sia ora sia in una possibile società post-capitalistica, solo attraverso una mediazione e una sintesi, al più alto livello democratico e partecipativo possibile, degli interessi specifici dei vari strati sociali, che non saranno mai identici neanche andando oltre il capitalismo. Per questo vanno rifiutate le reductio ad unum tipiche del comunismo novecentesco, miranti a sciogliere forzosamente gli interessi specifici e i concreti Beni comuni in un ipotetico interesse generale, disegnato da una leadership “illuminata” (il Partito-guida) che voglia schiacciare gli obiettivi specifici ed attuali non in nome di mediazioni democratiche ma in base, come nel “socialismo realizzato”, ad un progetto di presunta palingenesi dell’umanità.
6) Una reale socializzazione e democratizzazione integrale di quelli che vengono giudicati collettivamente Beni comuni – un innovativo Welfare universale, associato a vecchi e nuovi diritti globali – non può realizzarsi attraverso la semplice statalizzazione. Come ho cercato di dimostrare nel capitolo precedente, la struttura statuale è dominata da una nomenclatura/neo-classe che fa derivare il proprio potere dalla politica separata e di mestiere, che le consente di espropriare di fatto quanto sia stato reso comune e collettivo, grazie alla possibilità di poter decidere in autonomia gli usi dei mezzi di produzione, distribuzione e commercializzazione statalizzati, nonché del capitale derivante dalla tassazione dei cittadini/e.
7) Comunque si realizzi l’esproprio dei Beni comuni dalle mani del capitale privato e di Stato, non è affatto necessario, ed è anzi dannoso, che questa espropriazione si estenda a qualunque forma di attività e iniziativa privata, che riguardi la piccola produzione, distribuzione, commercio e fornitura di servizi. Una volta che i principali e significativi Beni comuni, mezzi di produzione e finanziari, che incidono in maniera decisiva sulla vita di tutti/e, siano tutelati da scelte collettive per il benessere generale, non può costituire un ostacolo o intralcio a tale sviluppo solidale il fatto che piccole proprietà agricole o industriali, beni non determinanti e decisivi nello sviluppo sociale, attività di piccolo commercio e distribuzione, artistiche e culturali, sportive e ricreative, turistiche e ludiche, artigianato manuale e intellettuale, ristorazione e accoglienza, trasporto privato siano gestiti da singoli cittadini/e o da gruppi associati, naturalmente in maniera virtuosa, cioè rispettando i criteri ambientali, sociali, di igiene pubblica che le strutture democratiche decideranno in merito, nonché la corretta retribuzione e gli orari contrattuali degli eventuali dipendenti e con un’equa tassazione degli introiti.
8) La vera incognita di una radicale trasformazione verso una società dei Beni comuni, come ho provato a tratteggiare in queste brevi note, riguarda le forme di democrazia partecipata in grado di garantire effettivamente la collettivizzazione e socializzazione dei principali mezzi di produzione, del capitale di Stato e dell’insieme dei Beni comuni, forme che evitino una nuova sottrazione dei Beni da parte di un potere statale in mano a inamovibili professionisti politici e istituzionali. Tema cruciale e assai complesso, perché riguarda l’estensione del concetto e delle pratiche di democrazia da diritto a dovere collettivo, spettante ad ogni cittadino/a, al fine di escludere, o limitare al massimo, l’esercizio monopolistico di essa da parte dei professionisti politici e istituzionali. E proprio alla complessità e alla centralità del tema dedicherò un prossimo scritto.
La statalizzazione totale, l’iniziativa privata e il consumo
Oltre agli aspetti politici e di gestione del potere fin qui analizzati, una specifica riflessione la merita la statalizzazione totale dei mezzi di produzione e di distribuzione, fino ai più piccoli e irrilevanti di essi, attuata in gran parte delle esperienze novecentesche di tentato superamento del capitalismo. Il ruolo onnipotente dello Stato nei “socialismi realizzati” non si è palesato solo nella gestione autocratica delle attività produttive, finanziarie, distributive e commerciali strategiche, ma intervenendo anche su ogni forma pur minimale di iniziativa e scambio privati, di fatto soffocandoli. Conseguentemente, in mancanza di strutture democratiche decisionali – in grado di esprimere la gamma dei reali bisogni e richieste di massa su cosa, come e per chi produrre e distribuire – lo Stato del modello sovietico/stalinista ha generato per lo più inefficienza produttiva, colossali sprechi, caos organizzativo e deficit disastrosi nel soddisfacimento dei bisogni di beni di consumo per gran parte delle popolazioni, con insopportabili carenze anche rispetto agli oggetti più elementari e più diffusi in Occidente. In tali campi, cruciali per la soddisfazione dei cittadini/e, l’incuria, l’inefficienza e la confusione produttiva e distributiva hanno finito, soprattutto a fronte dei balzi di qualità del Welfare e del consumo in Occidente negli anni ’50, ’60 e ‘70, per esasperare i disagi quotidiani di larga parte della popolazione, ingigantendo nel contempo lo sviluppo di mercati “neri”, di corruzione diffusa in tutti i settori della società, disaffezione al lavoro e dilagare di lavori occulti; e, su tutto, insopportabili privilegi per la nomenclatura di Stato. L’ostilità dichiarata da parte del “socialismo” staliniano nei confronti dei ceti intermedi (la cosiddetta “piccola borghesia”) ha imposto un distruttivo processo di omologazione forzata di ogni attività economica al modello della società-fabbrica. Il vero e proprio terrore nei confronti della piccola impresa privata e delle piccole produzioni artigianali, agricole, commerciali, la convinzione che necessariamente esse riproducessero il dominio del grande Capitale sull’intera società, sono state concause cruciali della militarizzazione forzata dell’intera economia e delle conseguenti, profondissime lacerazioni sociali che spiegano l’altrimenti incomprensibile tracollo del “socialismo” dopo tanti decenni di dominio politico assoluto, avvenuto senza che alcun settore di massa si sia minimamente impegnato nella sua difesa, e anzi con un generale plauso popolare alla sua demolizione.
Ma tale impostazione ha lasciato una pesante eredità anche ad Ovest e in particolare nella sinistra anticapitalista europea e tanto più in quella italiana. La profonda divisione del mondo del lavoro – avvenuta nel dopoguerra italico tra lavoro dipendente e lavoro autonomo, tra il mondo operaio della grande e media industria e l’altrettanto vasto territorio della piccola iniziativa privata, delle microimprese comunque utili e rilevanti per la vita quotidiana della popolazione – è stato un lascito ideologico del “socialismo reale” che partiti e sindacati di matrice stalinian-soviettista hanno introdotto nella società e che ha pesantemente influenzato la sinistra antagonista post-‘68, che ha sviluppato una radicale diffidenza o ostilità verso ogni iniziativa economica e produttiva privata, indipendentemente dalle dimensioni, vedendo anche nelle microimprese una sorta di terreno di incubazione dello sfruttamento capitalistico. Tale divisione, fomentata e ingigantita ad arte dai poteri davvero forti, è poi degenerata anche in divisioni quasi macchiettistiche tra dipendenti pubblici, in gran parte descritti come fannulloni e super-garantiti, e lavoratori autonomi, inseriti in massa tra coloro che non pagano le tasse e che non rispettano i diritti dei lavoratori dipendenti, quando li hanno. E appunto, per quel che riguarda quel mondo conflittuale post-’68 che ha coinvolto le storie personali, politiche e sindacali di molti/e della mia generazione e di quella immediatamente successiva a cavallo del “decennio rosso”, tale contrapposizione è stata vissuta intensamente da una moltitudine di militanti che l’hanno poi lasciata in eredità agli antagonisti dei decenni successivi e fino ai nostri giorni, giungendo, a partire dal culto della centralità operaia e del potere palingenetico della classe lavoratrice “manuale” di fabbrica, ad ignorare o disinteressarsi completamente della sorte e delle condizioni di vita e di lavoro di tutto quell’enorme mondo non rientrante nella categoria del lavoro dipendente “tradizionale”.
Ora, venendo alla feroce crisi economica post-pandemica che ci attende, mi sembra che la contrapposizione tra le suddette categorie del lavoro e il disinteresse verso una parte peraltro maggioritaria di esse, vadano superati con uno sforzo collettivo di conoscenza, di indagine e di disponibilità all’ascolto e al dialogo da favorire tra tali categorie. Tanto più che, se posizioni fortemente operaiste e ostili all’iniziativa privata, pur se di dimensione ridotta, potevano essere comprensibili di fronte ad una struttura produttiva, dominata dalla fabbrica di grandi e medie dimensioni, quale quella degli anni ’50, ’60 e ’70 del secolo scorso, oggi esse appaiono decisamente fuori tempo massimo alla luce delle profondissime trasformazioni economiche e produttive avviate dalla “rivoluzione informatica”, dall’ultima parte degli anni ’70 in poi, in Europa e in Italia. Oggi quelli che qualche decennio fa potevano essere considerati lavori atipici sono divenuti del tutto tipici e anzi decisamente maggioritari: e i numeri lo confermano senza ombra di dubbio. Prendendo ad esempio i dati italiani del 2019, nell’industria grande, media e piccola hanno lavorato circa (tutti i numeri che seguono sono approssimati alla più vicina cifra tonda) 4 milioni e 200 mila persone e nell’edilizia 1 milione e 300 mila edili; i dipendenti pubblici, statali, regionali o comunali, sono stati 3 milioni e 200 mila (di cui poco più di un terzo nella scuola); mentre nei servizi hanno lavorato 15 milioni e 300 mila persone, di cui 4 milioni e mezzo nel commercio, turismo, ristorazione e accoglienza. Per un totale di circa 24 milioni di lavoratori così divisi/e in percentuale: il 23% nell’industria ed edilizia; il 13, 5% nel Pubblico impiego; il 63,5% nei servizi; dati che dovrebbero bastare per spingere a guardare al lavoro in maniera decisamente diversa dagli anni post-‘68.
Tanto più che,
rispetto ai miti della grande fabbrica e delle grandi unità produttive di un
tempo, ci sono altri dati persino più rilevanti a proposito delle dimensioni delle
strutture produttive prevalenti. E’ piuttosto noto che nel tessuto produttivo
italiano siano dominanti le cosiddette PMI (Piccole
e Medie imprese: sono classificate “piccole” quelle ove lavorano
non più di 50 persone e “medie” quelle non oltre i 250 lavoratori/trici),
ma é assai meno conosciuto, almeno tra molti/e di coloro che agiscono negli
ambiti sindacali e lavorativi tradizionali, quali sono le dimensioni prevalenti
nell’ambito delle stesse PMI. Ebbene, mentre
l’82% dell’occupazione privata in Italia, per un totale di circa 15 milioni di
persone, è collocata nelle PMI che sono il 92% delle imprese private
produttive, all’interno della categoria PMI il comparto di gran lunga
maggioritario è quello che non viene manco nominato nell’acronimo, e cioè le microimprese che occupano meno di 10 persone
e che sono addirittura il 90% del
totale delle PMI; e di esse quelle con meno di 5 lavoratori/trici danno lavoro al 25% degli occupati
complessivi nel 2019.
Oltre a rappresentare una quota così massiccia dei lavoratori/trici occupati
fino all’esplosione della pandemia, questi
settori sono quelli che mediamente stanno pagando di più la chiusura totale ed
anche quelli che hanno le maggiori probabilità di non riaprire proprio, per
giunta trascinandosi dietro un mare di debiti. In nome della sacrosanta tutela
della salute collettiva, lo Stato e il governo li hanno obbligati a chiudere
per mesi le proprie attività e ora, invece di risarcirli rapidamente per queste
perdite loro imposte, hanno saputo solo proporgli la insultante beffa di un
rinvio di qualche mese del pagamento delle tasse, dell’IVA, dei contributi Inps
e delle bollette per i consumi energetici e per i rifiuti (che oltretutto
vengono loro caricati a tariffe doppie e a volte persino triple rispetto agli
analoghi consumi privati), che li costringerebbero ad accumulare ulteriori debiti
e a doverli pagare proprio mentre la riapertura avviene tra mille paure e
condizionamenti e quindi con ben poca clientela. Stiamo parlando di buona parte
delle “piccole” partite IVA, di bar, negozi, artigianato, attività artistiche, culturali e creative
(ben 290 mila strutture, che l’anno scorso hanno fatturato 96 miliardi e dato
lavoro a un milione e 550 mila persone), attività sportive (professionistiche, ma
soprattutto dilettantistiche, che coinvolgono milioni di giovani e meno giovani
– solo nel calcio un milione e trecentomila tesserati e circa mezzo milione di
persone che ci vivono – in decine di sport che impiegano circa un milione e
mezzo di persone), gran parte del turismo (che produceva il 14% del PIL) e
degli alberghi, la ristorazione (300 mila strutture con una media di 3-4
dipendenti, oltre un milione di occupati/e), il trasporto privato (taxi e Ncc),
parrucchieri, estetisti e fisioterapisti
(tre categorie che insieme arrivano a circa 400 mila lavoratori/trici) ecc.
Insomma, guai a ignorare o a sottovalutare questo mondo enorme, che peraltro a
lavorare ci vorrebbero tornare di corsa, perché ogni giorno che passa scava
loro una fossa più profonda, e i cui redditi medi, salvo poche eccezioni, per
lo più non superano lo stipendio di un insegnante o di un operaio
specializzato, e in genere con oneri maggiori e minori, o nulle, garanzie di
continuità degli introiti, di pensioni o coperture sanitarie.
Ma, al di là della congiuntura, nella sinistra conflittuale andrebbe cambiata la visione di questo mondo di iniziativa privata, una volta che si sia, una volta per tutte, rifiutata la prospettiva della trasformazione dell’intera società in una sorta di grande fabbrica unificata nelle mani di uno Stato onnipresente che mette bocca e mani dappertutto, infilando ovunque la sua burocrazia e le sue clientele, che nel caso italiano non ha manco il pregio dell’efficienza e delle competenze ad esempio del modello tedesco. E se in particolare si ha una buona conoscenza della burocrazia/borghesia di Stato italica e delle sue nefandezze storiche, per quale ragione dovremmo ritenere auspicabile l’abolizione della proprietà privata di qualsiasi mezzo produttivo o di distribuzione, anche il più minuto e limitato? E perché dovrebbe essere statalizzata ogni forma di produzione di oggetti non “strategici” ma non per questo inutili, e anzi generalmente desiderabili, di consumo specifico? Che si tratti di sport o di attività fisica e salutista, di turismo, arte, musica, cinema, teatro e spettacolo, di abbigliamento o moda in genere, ristoranti, bar o alberghi, produzione artigianale o piccola produzione agricola familiare, piccoli allevamenti, perché dovrebbe entrarci lo Stato, se non per garantire un’offerta di base (ad esempio per quel che riguarda le attività sportive o la cultura) e per assicurare che l’iniziativa privata, lasciata libera di operare senza interferenze stataliste, sia virtuosa, cioè rispetti le regole ambientali, igieniche, la corretta retribuzione dei lavoratori/trici, nonché una equa tassazione? Mi auguro che tra chi oggi lotta per la giustizia sociale, economica e ambientale si ritenga che queste domande siano retoriche e la risposta scontata. Ma se così é, ora che si sta delineando, come mai nel dopoguerra, il rischio di un possibile conflitto frontale, una sorta di strisciante “mini-guerra civile” tra garantiti e non-garantiti (stavolta a ragion veduta e non come nel caso di analoghe categorizzazioni ad minchiam degli anni ’70, modello Asor Rosa), credo che dovremmo darci da fare per attenuare o far cadere possibili muri di separazione, prestando orecchio a questo vasto mondo da noi spesso ignorato o trascurato, anche fornendo – nella speranza che da tale mondo cada una certa diffidenza storica nei confronti di chi, come ad esempio i COBAS, ha dedicato il proprio impegno quasi esclusivamente alla difesa del lavoro dipendente “tradizionale” – strumenti di difesa sindacale a settori del lavoro non abituati a risposte collettive e che si troveranno nei prossimi mesi in una solitudine radicale.
E ragionando in termini più universali, come visione del mondo e prospettiva culturale e sociale d’insieme, dovremmo forse anche mettere da parte, a proposito di consumi, oggetti e merci al di là delle produzioni ritenute collettivamente strategiche, le separazioni nette tra quelle utili e inutili, necessarie o superflue, tra i consumi fondamentali e quelli “condannabili”, e accettare l’idea che su utilità/inutilità, indispensabile/ eliminabile si debba lasciare alla libera scelta delle persone tracciare un confine. Personalmente, ad esempio, metterei le attività sportive addirittura tra le necessità strategiche, ritenendo che svolgerle costantemente, dall’adolescenza fino alla più tarda età possibile, oltre a migliorare vistosamente le condizioni degli individui, assai probabilmente dimezzerebbe la spesa sanitaria nazionale; mentre altri/e, che non fanno di solito manco le scale a piedi, pensano magari che ben altri siano le attività e i consumi indispensabili. Dunque, andrebbe superato anche un certo assolutismo anticonsumista, peraltro sovente solo parolaio o rivolto al consumo altrui, incapace di una visione dialettica che ne sappia leggere la duplicità, e che dà un valore eccessivo agli aspetti più parossistici, e certo deprecabili, del consumo monomaniaco. Ad esempio, affermare con sicumera sprezzante che i consumi, gli oggetti e le merci in generale “servono al denaro e non a chi le usa”, equivale a dire che la grande maggioranza dei prodotti venduti come merce non abbia alcun valore d’uso, che essi siano inutili e che vengano comprati da una massa di zombie solo perché pubblicizzati da mane a sera: ed è una tesi altrettanto estrema di quelle che descrivono un capitalismo parassitario che oramai vive solo facendo denaro con il denaro e saltando il passaggio della produzione e della vendita di oggetti concreti. Che il produttore sia interessato al profitto è un’ovvietà: ma per ottenerlo, egli deve vendere la merce; e perché ciò avvenga, occorre che dall’altra parte ci sia un compratore interessato all’oggetto, alla sua materialità e al suo uso. Per quanto ci si affanni a dimostrare che oramai si compra il logo, il brand, il significato simbolico dell’oggetto, nella realtà concreta della grande maggioranza delle persone si comprano oggetti perché vengono ritenuti utili e necessari per la vita quotidiana, per migliorarla, renderla più facile o più gradevole.
Se guardiamo ad esempio all’ultimo grande interesse di massa, l’attrezzatura informatica, telematica, comunicativa, ludica e cognitiva – insomma, dal computer al tablet, dallo smartphone all’iPad, dall’iPod, ai videogiochi e ai social – si può deprecarne gli eccessi o ironizzare sulla smania di essere permanentemente collegati con social network, followers o “amici” virtuali, o essere preoccupati per l’ondata di solipsismo che tutto ciò può determinare in una parte considerevole di giovani e meno giovani. Ma se prescindiamo dai loro usi distorti o monomaniaci, e osserviamo gli oggetti di per sé, sarebbe da seguaci di sette religiose tipo Amish affermare che si tratti di oggetti inutili. Sono dispositivi che consentono di collegarti con il mondo in pochi secondi, che ti mettono letteralmente in mano tutto lo scibile documentato, tutta la produzione letteraria, artistica, culturale in circolazione; che ti raccontano e descrivono il territorio, le condizioni climatiche e l’insieme dei servizi offerti nei luoghi ove ti trovi; che ti mettono in contatto con chiunque o qualunque cosa ti occorra; che ti guidano passo passo, per strada o meno, in zone non conosciute. Ignorare questo straordinario progresso tecnico e svalutarlo come superfluo o addirittura dannoso, e comunque vederne solo l’aspetto mercificante – il guadagno del produttore – significa operare una dicotomia ideologica che non ha riscontro nella realtà, leggendo nelle merci concrete solo il valore di scambio e fingendo che esse non abbiano più alcun valore d’uso. Invece il valore d’uso permane eccome, per milioni di oggetti, che siano cibi o vestiario, attrezzature sportive, per le abitazioni o per i veicoli, libri o musica, arte e svago: e la grande maggioranza della popolazione che li compra non lo fa, almeno in prevalenza, per monomania consumistica, ma perché buona parte di tali oggetti migliora la qualità dell’alimentazione, della salute, delle abitazioni, della comunicazione, dell’abbigliamento, della cura del corpo, della mobilità; cose che intrigano da secoli l’umanità, che ad analoghi oggetti utili ha dedicato sempre tempo, attenzione e risorse.
D’altra parte se così non fosse, come diceva icasticamente una celebrità dei decenni scorsi, «basterebbe mettere la merda in belle scatole con belle etichette» per fare profitto. E comunque, bisognerebbe stare molto attenti a maneggiare il concetto di utilità. LaGiocondao iBronzi di Riacesono utili? Per coloro che amano l’arte sì, ne arricchiscono lo spirito e il gusto estetico. Ma è deprecabile che altri/e provino piacere per le bellezze di un vestito o di una moto, di un mobile o di un utensile da cucina, oggetti prodotti per sollecitare anch’essi un pur diverso gusto estetico? Bellezze finalizzate alla vendita dell’oggetto? Certo: ma anche quadri e sculture furono (e sono) prodotti per essere venduti. E di per sé le passioni delle corti reali dei secoli passati per i monili o per le bellezze artistiche non mi sembra che vadano considerate più nobili di quelle odierne per prodotti forse più prosaici ma contenenti scienza, abilità tecnica e gusto estetico spesso di valore non trascurabile. Non avrebbe grandi capacità attrattive una società post-capitalistica ove un qualsivoglia potere, di fronte agli oggetti, dovesse stabilire il confine tra utile ed inutile, eliminando la produzione di quelli non “spartani”. Prospettiva che ci riporterebbe all’estremo opposto del consumismo sfrenato, ma con effetti altrettanto deleteri, come ha dimostrato la parabola del “socialismo reale”, una delle cause principali del cui disastro è stata proprio l’incapacità di dare ai lavoratori e ai cittadini migliori condizioni di vita quotidiana non solo tramite la scuola, la sanità e i servizi, ma anche fornendo loro la possibilità di curare, sì con intelligenza ed equilibrio ma anche con gusto e varietà, l’alimentazione, l’abbigliamento, il corpo, la mobilità, i divertimenti, il tempo libero. Incapaci come sono stati di utilizzare la scienza e la tecnica non solo per costruire atomiche e satelliti spaziali, ma anche per evitare quella catastrofica penuria di qualsivoglia cosa utile per il buen vivir quotidiano, a causa della quale i cittadini “socialisti” dovevano fare le proverbiali, chilometriche ed estenuanti file quotidiane per l’approvvigionamento di “merci” (scarse in quantità e in qualità) che avevano certo basso prezzo ma ancor minore valore d’uso. E comunque, restando all’oggi, non ci si oppone efficacemente al capitalismo solo denunciandone la sete di profitto e trascurandone la capacità di affascinare gli umani assecondandone i più vari desideri, in parte certo indotti dalla propaganda del venditore, ma in parte quasi innati o comunque operanti da decine di secoli. Insomma, guai ad ignorare il lato diabolicamente attraente degli oggetti, che blandisce miliardi di individui che non vivono il consumo come “obbligo zombesco”, bensì come strumento di miglioramento della vita quotidiana e di appagamento di desideri e passioni.
Piero Bernocchi
9 maggio 2020