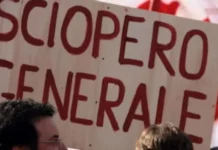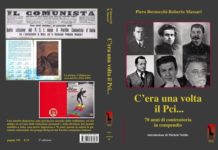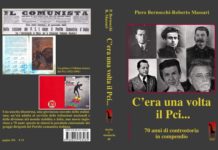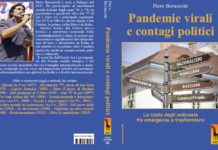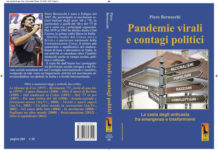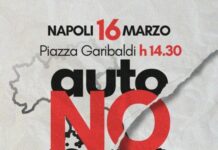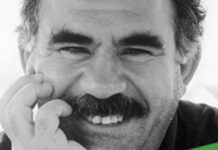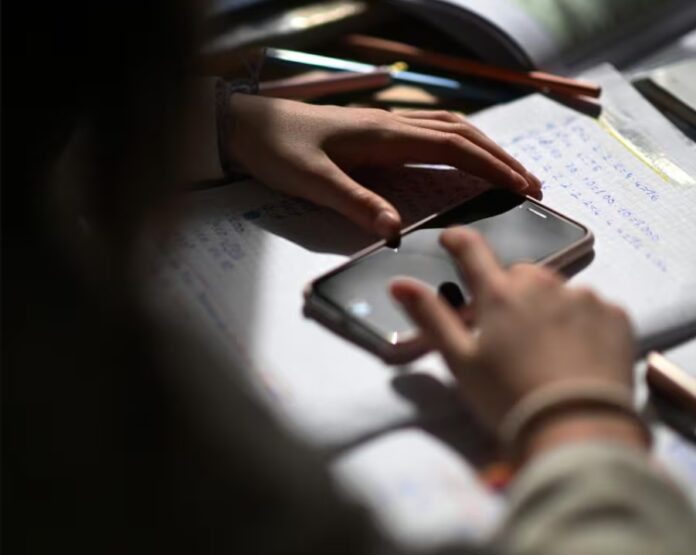La decisione del ministro Valditara di vietare a scuola l’uso degli smartphone in classe, in combinazione con la polemica sempre-verde sulla “nefasta” influenza degli smartphone/social sui giovani (ma anche sui meno giovani, sottolinerei nel caso), ha riacceso una vivace discussione nella parte di società attenta al ruolo della scuola nella formazione delle nuove generazioni, e in primo luogo tra i docenti e le famiglie con figli/e in età scolare. Di per sè il provvedimento sembra di elementare buonsenso: se devi seguire una lezione non puoi trastullarti con lo smart, se devi fare un compito in classe o rispondere a domande didattiche non puoi farlo usando Internet. E anzi, questa decisione arriva casomai tardi a livello internazionale , visto che (dati del Global Education Monitoring/UNESCO) a fine 2024 ben 79 paesi avevano già adottato il provvedimento. Quello che stona è il fatto che il provvedimento è stato accompagnato dal plateale tentativo del ministro di caricare la decisione di un impatto educativo “epocale”, sostenendo che il provvedimento servirà a dimostrare ai/alle ragazzi/e in età scolare quanto sia dannoso l’abuso dello smart (e magari anche quello dei social), da una parte contribuendo a “risanarli” dagli effetti “droganti” del mezzo e dall’altra dando sfoggio di un presunto rigore didattico-educativo e di un ritorno alla “scuola seria e impegnativa” che Valditara e il governo in generale si piccano di ben predicare, razzolando poi male.
Certo, vi è oramai un consenso diffuso sul fatto che un uso smodato degli smartphone (come dei social e della “vita in Rete”) provochi a tanti/e giovani ansia, deficit di apprendimento e cognitivo, carenze relazionali e difficoltà di conciliare la vita virtuale da smart/social con quella reale, nonchè una dipendenza dal “drogaggio informatico” spesso pesante e alienante. Ma sostenere che questa condizione possa essere esorcizzata con una “astinenza” forzata nelle 4-5 ore scolastiche giornaliere è pura retorica nonchè un tentativo smaccato di captatio benevolentiae nei confronti delle famiglie: soprattutto se non si considerano le varie e profonde ragioni della fascinazione che smart/social esercitano non solo sui giovani ma anche su individui che, rispetto ai “nativi digitali”, dovrebbero essere immuni nei confronti del “contagio”, avendo effettuato il percorso educativo quando di smart/social non vi era traccia.
Un paio di anni fa, alla ripresa delle lezioni, scrissi un articolo, L’esercito del selfie, in cui cercavo di trattare la complessità dell’uso degli smart/social/selfie: uso che supera ogni barriera di generazione, collocazione sociale, etnia, nazione, livello economico, coprendo pressoché l’intero pianeta in maniera omogenea. Cercavo di dimostrare come fosse semplicistico fotografare il fenomeno epocale come se si trattasse di una sorta di ipnosi universale indotta dal “sistema” o di una dimostrazione di sudditanza globale e acefala alla potenza tecnologica dell’immagine e dell’informazione a flusso continuo: e soprattutto senza tener conto delle “gratificazioni” e delle emozioni/passioni che il fenomeno alimenta tra milioni (anzi, oramai miliardi) di individui di ogni età e collocazione sociale e territoriale. Richiamavo l’attenzione in particolare sull’enorme influenza che sul fenomeno planetario giocava il desiderio di protagonismo individuale, che i social/smart e la Rete telematica globale possono oggi, almeno sulla carta, garantire a chiunque, andando ben oltre il celebre motto di Andy Warhol sul “quarto d’ora di notorietà” che la società dello spettacolo e della comunicazione/informazione può promettere a chiunque. Per la verità, all’epoca il mio obiettivo era più limitato di una trattazione a tutto campo dell’argomento, perchè mi interessava affrontare il problema soprattutto per delinearne gli effetti negativi sul protagonismo collettivo, in particolare su quello politico/sindacale/sociale di base (e quindi anche sull’attivismo COBAS).
La mia argomentazione utilizzava varie esperienze che ho fatto negli ultimi anni, in particolare in assemblee COBAS e convegni CESP. Laddove sovente avevo provato a dare una spiegazione non convenzionale di un fenomeno descritto negli ultimi tempi da parecchi insegnanti: e cioè, appunto, l’ossessiva necessità della maggioranza degli studenti di avere con sè in consultazione continua lo smartphone, al punto da manifestare una “crisi di astinenza” se ne vengano separati durante le lezioni. Ricordo in particolare un docente che segnalava come, nel caso che vi siano stati chiusi gli smart, tanti studenti guardino gli armadietti come se ci fosse imprigionato un animaletto amato e sofferente per la “clausura”. In tali consessi, ho espresso l’opinione che non si trattasse di un rincoglionimento collettivo o di processi “decerebranti” degli smart/social, ma di qualcosa di più complesso e profondo, e cioé di un bisogno spasmodico di protagonismo individuale. E per spiegarmi, ho fatto un paragone con un’analoga necessità, seppur su livelli di protagonismo ben più motivati e “produttivi”, dei politici in carriera: quello di restare in permanenza collegati con i social e di dare in continuazione segnali della propria presenza nelle quotidiane polemiche politiche. Ho avanzato l’ipotesi che la stessa frenesia di protagonismo social del politico in carriera, o dell’intellettuale o del sindacalista celebre colpisca anche milioni di giovani che sentono un’analoga necessità di segnalare la propria presenza nell’agone sociale, amicale, familiare, con il conseguente bisogno di non staccarsi mai dal dialogo incessante con i propri follower o più semplicemente con i gruppi sociali e amicali con i quali siano in collegamento permanente.
Si può obiettare che i due piani non siano paragonabili. Però, a controprova, segnalerei innanzitutto il successo cosmico di milioni di influencer, sia quelli/e dotati di abilità specifiche, ma sia anche di “giovani qualunque”. come quel Khaby Lame, che dal suo lavoro precario perso nel 2020 a venti anni, ha guadagnato in tre anni oltre cento milioni di followers in tutto il mondo sbeffeggiando su Tik Tok, senza parlare, la banalità dei video di altri frequentatori social, divenendo poi una star del mondo dello spettacolo. Possiamo sottovalutare l’effetto imitativo di questi casi, per quanto oramai dilaganti, di improvviso successo planetario di persone che, senza alcuna abilità professionale, riescono a raggiungere una notorietà globale. Ma non possiamo ignorare almeno il fatto che milioni di giovani e meno giovani si accontentano di una notorietà assai più limitata, magari in una cerchia di amici, familiari, colleghi di lavoro e “amicizie virtuali”accumulate nei social, al fine di uscire dall’oramai insopportabile anonimato che segnava, prima del trionfo dei social, miliardi di individui che non svolgevano attività politiche, economiche o sociali di una qualche rilevanza. Se si comprende quanto sia divenuta pressante tale esigenza, allora si capisce perchè, per guadagnarsi una seppur circoscritta notorietà, essi/e devono competere quotidianamente – con un impegno continuo che rende indispensabile aver sempre a portata di mano l’”attrezzo da lavoro” mediatico – con tutti/e gli altri/e che cercano una qualche visibilità. E la cosa va ben oltre le generazioni o i confini territoriali. Chiunque abbia la ventura di viaggiare nei luoghi più disparati e diversi verifica quotidianamente quanto sia dilagante – e superi barriere geografiche, di tradizioni, religioni, etnie, modelli culturali e stili di vita – il desiderio di emergere in qualche modo dall’appiattimento universale, di essere protagonisti almeno in alcune cerchie di vicinanza, di ottenere l’approvazione e la curiosita degli altri/e su se stessi almeno per qualche tempo. Insomma, qualcosa di più complesso del semplice narcisismo: un irresistibile desiderio di dare segno di sè, di lasciare una traccia , fosse pure nelle piccole conventicole delle proprie chat.
Se poi a tutto questo aggiungiamo l’effetto affascinante di ricevere notizie di ogni genere, immagini, video, musiche e quant’altro, da tutto il mondo e senza soste, l’idea di separare da questo flusso continuo, per tanti/e vivificante, milioni di giovani con la “sospensione” di alcune ore scolastiche, sia del tutto illusorio. Non si può negare però che una igiene didattica ed educativa il provvedimento, se ben gestito nelle scuole, la possa realizzare, senza che se ne debbano millantare epocali effetti positivi al di là della scuola. Perchè è davvero impensabile che un docente riesca a svolgere bene il proprio lavoro educativo e formativo nei confronti di alunni/e che nel contempo siano impegnati/e a seguire il fluire continuo delle chat del proprio gruppo di appartenenza o l’osservazione ininterrotta di quel che gira senza sosta sullo smart. Ed è altrettanto impensabile che si possano svolgere verifiche serie delle conoscenze, se lo studente ha la possibilità di surrogare un sapere deficitario facendo ricorso all’immane competenza contenuta nella Rete e fruibile grazie allo smart. Anzi, credo che oramai i/le docenti dovrebbero aver realizzato che, con l’avvento dell’Intelligenza Artificiale, sia il processo della trasmissione del sapere (neanche il/la più bravo/a docente al mondo può competere in qualsiasi materia con l’oceanica conoscenza immagazzinata in Rete che la IA sintetizza e offre in tempi fulminei), sia quello delle verifiche di competenze/conoscenze dell’alunno/a vadano rivisti alla radice.
Piuttosto, a proposito di docenti, darei per scontato che il divieto – che comunque andrà introdotto con duttilità e diplomazia nelle scuole e concordato/condiviso con gli studenti – valga anche per i docenti. Che dovrebbero assolutamente evitare di annullare gli effetti dei provvedimento cercando con artifici vari (e prevedibili richieste di esenzione) di scansarlo per sè. E, in più, estenderei tale divieto a tutta l’attività scolastca oltre le lezioni, e dunque anche ai Collegi, ai Consigli di classe e a tutte le attività in cui l’attenzione docente, come quella del discente in classe, non dovrebbe essere fuorviata dall’intervento del “fascinoso e conturbante” smartphone.
Piero Bernocchi